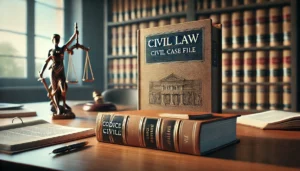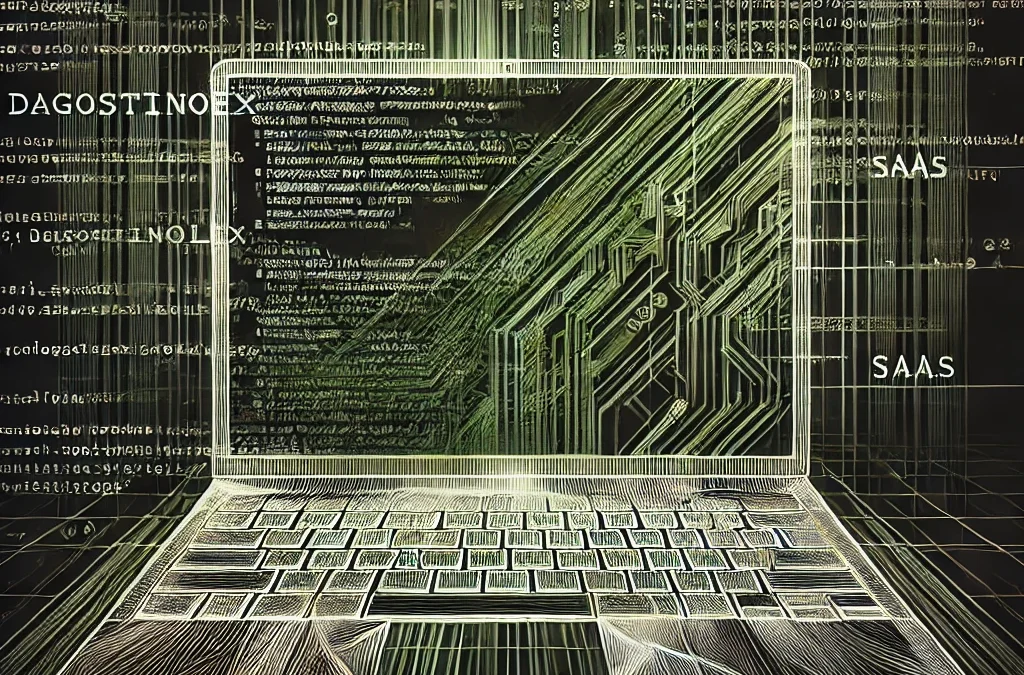da Redazione | Gen 27, 2025 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi
Il tema del comodato d’uso del veicolo assume una rilevanza sempre maggiore nell’ambito della regolamentazione della circolazione stradale, soprattutto in virtù delle recenti disposizioni normative che mirano a garantire una maggiore tracciabilità e trasparenza nell’utilizzo dei veicoli. La normativa vigente pone l’attenzione sui casi in cui un veicolo sia utilizzato da un soggetto diverso dall’intestatario per periodi prolungati, introducendo specifici obblighi di annotazione sulla carta di circolazione.
Il quadro normativo di riferimento è delineato dall’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, che sancisce l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli la disponibilità del veicolo da parte di un soggetto terzo per un periodo superiore a trenta giorni. Tale disposizione, introdotta per garantire un controllo più rigoroso nella circolazione dei veicoli, si applica a situazioni quali contratti di comodato, affidamenti giudiziali o altre forme di utilizzo continuativo del mezzo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario.
In aggiunta, il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, all’articolo 247-bis, fornisce ulteriori dettagli applicativi, introducendo specifiche eccezioni all’obbligo di annotazione. In particolare, viene chiarito che l’obbligo non si applica ai componenti del nucleo familiare convivente con l’intestatario del veicolo, garantendo in tal modo una maggiore flessibilità per i rapporti familiari. Questa previsione normativa, dunque, solleva i familiari conviventi dall’onere di adempiere agli obblighi burocratici, purché la convivenza possa essere documentata secondo i criteri anagrafici previsti dalla legge.
Con questo articolo, in linea con altri approfondimenti precedenti, si intende fornire ai lettori un breve approfondimento su questo tema, chiarendo gli ambiti di applicazione della normativa e le eccezioni previste, nonché evidenziando l’importanza di una corretta gestione degli adempimenti previsti dalla legge.
Comodato d’uso del veicolo e obbligo di annotazione sulla carta di circolazione
Il comodato d’uso del veicolo può rientrare tra i casi specificamente disciplinati dall’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, il quale impone l’obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi alla disponibilità del veicolo qualora esso venga utilizzato, per un periodo superiore a trenta giorni, da un soggetto diverso dall’intestatario. Questa norma si pone l’obiettivo di assicurare una maggiore tracciabilità e responsabilità nell’utilizzo dei veicoli, in particolare in quei contesti in cui un mezzo di trasporto venga concesso a terzi per un uso continuativo o stabile.
La ratio di tale disposizione normativa risiede nell’esigenza di garantire una gestione più trasparente del parco veicoli circolante, in modo da poter identificare con precisione il soggetto che, di fatto, utilizza il veicolo in modo continuativo. Ciò assume particolare importanza in materia di responsabilità amministrativa e civile derivante dalla circolazione stradale, nonché nell’ambito delle sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada.
Il comodato d’uso del veicolo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, comporta quindi un obbligo formale di comunicazione agli uffici competenti del Dipartimento per i Trasporti. Questa comunicazione si traduce in una modifica della carta di circolazione, nella quale deve essere riportato il nominativo del soggetto che ha la disponibilità del veicolo e, in caso di comodato scritto, la durata prevista dal contratto.
Tale obbligo, se non adempiuto, comporta specifiche sanzioni amministrative a carico sia del proprietario sia del conducente. Le sanzioni sono mirate a incentivare il rispetto delle norme e a garantire che il veicolo venga sempre utilizzato nel rispetto della disciplina di legge, specialmente in contesti di utilizzo prolungato da parte di terzi non rientranti nel nucleo familiare convivente.
La disciplina del comodato d’uso del veicolo conferma, dunque, l’importanza di gestire correttamente la documentazione relativa alla disponibilità del mezzo. Per evitare possibili sanzioni o contestazioni, è essenziale che gli utenti siano pienamente consapevoli dei propri obblighi legali e che, in caso di dubbi, si affidino a consulenti esperti per una gestione conforme agli adempimenti richiesti dalla normativa.
Comodato d’uso del veicolo a familiare convivente: esenzione dall’obbligo di annotazione
Un aspetto fondamentale della disciplina del comodato d’uso del veicolo riguarda l’esenzione dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione per i casi in cui il veicolo sia concesso in utilizzo a un familiare convivente dell’intestatario.
Tale esenzione è espressamente prevista dall’articolo 247-bis, comma 2, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, il quale specifica che l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non si applica ai componenti del nucleo familiare convivente.
Questa previsione normativa trova il proprio fondamento nella necessità di semplificare gli adempimenti burocratici in presenza di legami familiari e di una convivenza accertata. La ratio legis risiede nell’idea che i membri di uno stesso nucleo familiare, pur utilizzando un veicolo intestato a un altro convivente, non necessitano di particolari formalità aggiuntive per documentare tale utilizzo, poiché la convivenza garantisce un presupposto di tracciabilità e responsabilità condivisa. Tuttavia, per poter beneficiare di questa esenzione, la convivenza deve essere adeguatamente documentata tramite i registri anagrafici comunali.
L’interpretazione della norma porta a chiarire che l’esenzione si applica esclusivamente ai soggetti che coabitano stabilmente con l’intestatario del veicolo. Ciò esclude, ad esempio, parenti o familiari che, pur avendo rapporti stretti con il proprietario, non risiedono nella medesima abitazione. È quindi essenziale verificare con attenzione lo status anagrafico del nucleo familiare al momento dell’eventuale controllo da parte delle autorità competenti.
Nonostante l’esenzione dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione, è importante sottolineare che il conducente familiare convivente deve comunque rispettare tutte le altre disposizioni del Codice della Strada, incluse quelle relative alla disponibilità dei documenti di circolazione e alla responsabilità derivante dalla conduzione del veicolo.
Il comodato d’uso del veicolo tra non conviventi: obblighi e sanzioni
La disciplina del comodato d’uso del veicolo diventa particolarmente stringente nei casi in cui il mezzo sia concesso in utilizzo a soggetti non conviventi con l’intestatario. In tali circostanze, l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, previsto dall’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, assume carattere imperativo.
La norma, infatti, impone di comunicare formalmente agli uffici del Dipartimento per i Trasporti l’identità del conducente che ha la disponibilità esclusiva e continuativa del veicolo per periodi superiori a trenta giorni.
A differenza dei casi di utilizzo da parte di familiari conviventi, per i quali è prevista un’esenzione, il comodato d’uso del veicolo a soggetti terzi richiede l’adempimento di precise formalità. L’intestatario del veicolo e il conducente devono infatti stipulare un contratto scritto di comodato, in cui siano indicati chiaramente i termini e le condizioni d’uso del mezzo, nonché la durata del rapporto. Tale contratto, una volta redatto, costituisce il presupposto per richiedere l’annotazione dei dati del comodatario sulla carta di circolazione.
La mancata osservanza di questi obblighi comporta conseguenze rilevanti. L’omissione dell’annotazione, infatti, espone sia il proprietario del veicolo sia il conducente a sanzioni amministrative, come previsto dal Codice della Strada (pagamento di una somma da € 727 a € 3.629, come previsto dall’art. 94, comma 3, CdS). Le sanzioni sono finalizzate a incentivare il rispetto delle norme e a garantire la tracciabilità dell’effettivo utilizzatore del veicolo, in un’ottica di sicurezza stradale e di corretta gestione delle responsabilità derivanti dalla circolazione.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda i controlli stradali: in caso di mancata annotazione del comodato d’uso del veicolo, le autorità competenti potrebbero presumere l’irregolarità dell’utilizzo e procedere con le relative contestazioni. Per evitare tali problematiche, è fondamentale che entrambe le parti coinvolte rispettino scrupolosamente le procedure previste dalla legge, documentando formalmente il rapporto di comodato e garantendo l’aggiornamento della carta di circolazione nei tempi richiesti.
Comodato d’uso del veicolo e consulenza legale
Il comodato d’uso del veicolo è un istituto spesso negletto e poco conosciuto, che bilancia le esigenze di tracciabilità e sicurezza nella circolazione stradale con la necessità di semplificazione per determinati rapporti giuridici.
Il quadro normativo presenta alcune incertezze applicative che possono generare dubbi su particolari adempimenti. In particolare, è fondamentale comprendere quando sia necessario procedere con l’aggiornamento della carta di circolazione e quali siano le implicazioni derivanti dalla mancata osservanza di tale obbligo. La presenza di eccezioni, come quella relativa al comodato d’uso del veicolo tra familiari conviventi, richiede una corretta documentazione della convivenza e una conoscenza approfondita dei requisiti previsti dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che una gestione conforme degli adempimenti previsti è essenziale per evitare sanzioni amministrative e contestazioni da parte delle autorità competenti.
Lo Studio Legale D’Agostino, grazie alla sua consolidata esperienza nel settore, è in grado di fornire un supporto completo e personalizzato per tutti gli aspetti legati al Codice della Strada.
Per chiunque desideri approfondire ulteriormente queste tematiche o necessiti di assistenza nella gestione di tali adempimenti, rimaniamo a disposizione per una consulenza legale qualificata e orientata alla soluzione di problematiche specifiche.

Codice della Strada e comodato d’uso del veicolo: Studio Legale D’Agostino a Roma.

da Redazione | Gen 22, 2025 | Diritto civile
L’amministratore di sostegno è la figura che sovrintende alla tutela delle persone che, a causa di condizioni di fragilità fisica o psichica, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Questo istituto è stato concepito per garantire un supporto personalizzato a coloro che, pur mantenendo la capacità di compiere autonomamente alcuni atti, necessitano di un sostegno specifico per altre funzioni di rilevanza pratica o patrimoniale.
L’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), introdotta con la Legge n. 6/2004, si pone come una misura flessibile, capace di adattarsi alle esigenze specifiche del beneficiario, e mira a rispettare il principio dell’autodeterminazione della persona. A differenza dell’interdizione o dell’inabilitazione, che comportano una limitazione più ampia della capacità di agire, la nomina dell’amministratore di sostegno consente di preservare, per quanto possibile, l’autonomia residua del soggetto assistito, limitando l’intervento al solo ambito necessario.
Nell’ambito di questa guida, verranno esaminati tutti gli aspetti fondamentali relativi alla nomina dell’amministratore di sostegno, con particolare attenzione ai soggetti beneficiari, alle modalità di richiesta della misura, al procedimento giurisdizionale e ai compiti attribuiti all’amministratore.
L’obiettivo è fornire una panoramica completa che possa orientare chiunque necessiti di assistenza legale in questo ambito, valorizzando l’importanza dell’istituto quale strumento di protezione e supporto per i soggetti vulnerabili.
Amministratore di sostegno e beneficiari della misura
I presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno sono individuati nella presenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica tale da incidere sulla capacità di svolgere autonomamente le attività quotidiane. La legge si fonda su una concezione ampia di salute, che include non solo l’aspetto fisico ma anche quello psicologico e sociale, riconoscendo l’importanza di garantire al beneficiario un livello ottimale di benessere e inclusione.
Possono beneficiare della misura persone anziane con limitazioni fisiche o cognitive, soggetti affetti da disabilità fisiche o psichiche, persone con patologie degenerative o dipendenze (es. gioco d’azzardo o alcool), nonché coloro che soffrono di disturbi psichiatrici. L’obiettivo è sempre quello di assicurare un supporto mirato e proporzionato alle necessità individuali, rispettando la dignità e le aspirazioni del beneficiario.
Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno (art. 406 c.c.)
La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno può essere presentata da una pluralità di soggetti individuati dalla legge, al fine di garantire la più ampia tutela per il beneficiario. L’interessato stesso, anche se minore, interdetto o inabilitato, può proporre tale richiesta, dimostrando la propria consapevolezza rispetto alla misura di protezione necessaria.
Oltre a lui, il coniuge, purché non separato legalmente, e la persona stabilmente convivente sono tra i primi legittimati a presentare la domanda. Seguono i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché il tutore o il curatore eventualmente già nominati. Anche il pubblico ministero rientra tra i soggetti legittimati, con il compito di intervenire nei casi in cui la misura risulti indispensabile per garantire i diritti del beneficiario.
Un ruolo particolare è attribuito ai responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali, se a conoscenza di fatti che rendano necessaria l’amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare il ricorso o a darne notizia al pubblico ministero. È essenziale precisare che, nonostante possano essere coinvolti nel procedimento, gli operatori dei servizi sociali pubblici e privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono essere nominati amministratori di sostegno, per evitare conflitti di interesse e garantire la massima imparzialità della figura designata.
Nei casi relativi ai minori, il decreto di nomina può essere emesso solo nell’ultimo anno della minore età e diventa esecutivo al raggiungimento della maggiore età, assicurando una transizione lineare tra le tutele previste per il minore e quelle stabilite per l’adulto.
Infine, per i soggetti che non rientrano tra i legittimati attivi (es. amici o conoscenti), la legge consente di rivolgersi ai servizi sanitari e sociali o al pubblico ministero per sollecitare l’apertura del procedimento.
Come richiedere la misura e chi può assumere l’ufficio di amministratore di sostegno (art. 408 c.c.)
La nomina di un amministratore di sostegno è di competenza del giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario vive abitualmente (residenza o domicilio), il quale ha il compito di valutare la situazione personale e le necessità del soggetto interessato.
Nel caso in cui la persona sia ricoverata permanentemente presso una struttura per anziani o un’altra tipologia di residenza, la competenza territoriale è attribuita al giudice del luogo di ricovero.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, emesso dal giudice tutelare, è preceduto da un’attenta analisi delle esigenze del beneficiario. Il provvedimento non solo definisce le funzioni e i poteri attribuiti all’amministratore, ma orienta anche il processo di accompagnamento della persona fragile, in stretta relazione con i servizi di cura e assistenza disponibili sul territorio. Tali indicazioni sono fondamentali per garantire che la misura di protezione sia calibrata sulle specifiche necessità del beneficiario, rispettandone la dignità e i diritti fondamentali.
La scelta dell’amministratore di sostegno spetta esclusivamente al giudice tutelare, il quale deve agire nell’interesse del beneficiario. Coloro che richiedono la nomina possono indicare nel ricorso il nominativo di una persona ritenuta idonea a ricoprire tale ruolo.
In mancanza di una designazione specifica, il giudice privilegia figure appartenenti all’ambito familiare, come il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli, i fratelli o i parenti entro il quarto grado. Qualora non sia individuabile un familiare idoneo, il giudice può nominare un soggetto estraneo alla famiglia, privilegiando persone con esperienza o formazione specifica, come volontari che abbiano seguito percorsi formativi dedicati.
L’amministratore di sostegno, nello svolgimento delle sue funzioni, è tenuto a mettere al centro della propria attività le esigenze e le aspettative del beneficiario, mantenendo con quest’ultimo una relazione di fiducia. In caso di disaccordo sulle decisioni prese dall’amministratore, il beneficiario può rivolgersi al giudice tutelare per segnalare il problema e richiedere eventuali modifiche al provvedimento o alla gestione.
Perché rivolgersi a un avvocato/studio legale per la nomina di un amministratore di sostegno
Sebbene la nomina di un amministratore di sostegno non richieda obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato, è altamente consigliabile avvalersi della consulenza di un professionista legale per garantire un corretto svolgimento del procedimento e per tutelare al meglio gli interessi del beneficiario. L’avvocato, grazie alla sua competenza specifica, è in grado di supportare le parti coinvolte nella predisposizione della documentazione necessaria, nella redazione del ricorso e nella rappresentanza durante le udienze.
L’assistenza legale diventa indispensabile in situazioni particolarmente complesse, come nei casi in cui la posizione del beneficiario presenti aspetti di natura giuridica o economica di difficile gestione. Ad esempio, è opportuno rivolgersi a un avvocato qualora sussistano divergenze tra i familiari o con il potenziale beneficiario riguardo alla nomina dell’amministratore, o nel caso in cui la misura possa incidere significativamente sui diritti fondamentali della persona interessata, analogamente a quanto avviene nei procedimenti di interdizione.
L’avvocato può inoltre rappresentare un valido supporto per individuare la figura dell’amministratore di sostegno più idonea, garantendo che la nomina rispecchi le esigenze specifiche del beneficiario e sia conforme alle disposizioni normative. La sua presenza offre una garanzia di correttezza e professionalità, evitando eventuali contestazioni e garantendo un’esecuzione puntuale delle misure di tutela.
Contenuto del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno
Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno deve essere redatto con precisione, includendo tutte le informazioni necessarie per consentire al giudice tutelare di valutare adeguatamente la situazione del beneficiario. Innanzitutto, è necessario indicare le generalità complete del beneficiario e la sua dimora abituale, corredando il ricorso con la copia del documento d’identità sia del beneficiario che del ricorrente, nonché con lo stato di famiglia, utile a comprovare eventuali vincoli parentali.
È fondamentale specificare nel ricorso le ragioni della richiesta, allegando idonea documentazione medica rilasciata dai servizi sanitari o sociali che attesti l’esistenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica e l’impossibilità, anche parziale o temporanea, del beneficiario di provvedere ai propri interessi. Qualora si renda necessaria l’udienza presso il domicilio del beneficiario, per ragioni di intrasportabilità, è indispensabile allegare un certificato medico che ne attesti tale condizione.
Inoltre, devono essere elencati i nominativi, i domicili e i recapiti telefonici di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi del beneficiario, se conosciuti, specificando che la loro sottoscrizione del ricorso vale come adesione alla proposta di nomina. È altresì utile fornire una descrizione dettagliata delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario, unitamente a una panoramica del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, supportata da documentazione relativa, come estratti conto, visure immobiliari o societarie.
Infine, il ricorso deve contenere una chiara indicazione degli atti che si prevede debbano essere compiuti nell’interesse del beneficiario e un’indicazione delle spese principali, al fine di stabilire un importo mensile adeguato a soddisfare le sue necessità.
Se la persona proposta come amministratore accetta l’incarico, è necessario includere la sua dichiarazione di accettazione, con le relative generalità e recapiti. Per concludere, qualora il ricorso venga presentato da un soggetto diverso dal ricorrente, si deve allegare una delega scritta con copia del documento d’identità del delegato.
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (art. 407 c.c.)
Il giudice tutelare deve esaminare personalmente il beneficiario, assumere informazioni e, se necessario, disporre accertamenti, anche di natura medica. La presenza del beneficiario all’udienza è generalmente necessaria per assicurare il rispetto dei principi di partecipazione e autodeterminazione. Tuttavia, in caso di comprovata impossibilità di comparizione, è necessario fornire un certificato medico che attesti tale condizione.
Qualora il beneficiario non si presenti all’udienza, il giudice tutelare può disporre un rinvio, fissando una nuova data per consentire l’esame diretto.
In situazioni particolari, il giudice può recarsi presso il luogo in cui il beneficiario si trova, qualora venga prodotta idonea documentazione medica attestante l’assoluta intrasportabilità. Questa misura consente di tutelare al meglio i diritti e gli interessi della persona fragile, garantendo comunque una verifica diretta delle sue condizioni.
Una volta accertati i presupposti per la nomina, il giudice emette il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno. Questo decreto viene annotato a cura del cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno, conservato presso l’ufficio del giudice tutelare.
Inoltre, entro dieci giorni dall’emissione, il decreto viene comunicato all’ufficiale di stato civile, che provvede ad annotarlo a margine dell’atto di nascita del beneficiario. A garanzia della trasparenza e del controllo, il decreto viene anche iscritto nel casellario giudiziale, uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica per raccogliere e conservare i provvedimenti giudiziari.
Nei casi di necessità e urgenza, segnalati direttamente nel ricorso, il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, adottando un provvedimento immediato, anche prima dell’udienza o nel corso del procedimento.
Tale misura consente di affrontare tempestivamente situazioni critiche, come la necessità di autorizzare trattamenti sanitari urgenti o di intervenire in caso di gravi rischi patrimoniali. L’amministratore provvisorio, una volta nominato, è tenuto a prestare immediatamente il giuramento e a svolgere il proprio incarico fino alla conclusione del procedimento o alla nomina definitiva di un altro soggetto ritenuto idoneo.
Effetti della nomina e compiti dell’amministratore di sostegno
La nomina dell’amministratore di sostegno non comporta l’annullamento della capacità del beneficiario di compiere atti giuridici. A differenza dell’interdizione, il beneficiario mantiene la possibilità di compiere validamente tutti gli atti che non richiedono necessariamente l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore, e in ogni caso conserva il diritto di effettuare in autonomia gli atti necessari a soddisfare le esigenze quotidiane. Questa impostazione garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, salvaguardando al contempo l’interesse primario del beneficiario.
Il decreto di nomina, emesso dal giudice tutelare, definisce la durata dell’incarico e specifica i poteri dell’amministratore di sostegno, indicando gli atti che richiedono la sua assistenza o rappresentanza. Tale decreto è annotato a margine dell’atto di nascita del beneficiario e, al termine dell’incarico, il decreto di chiusura dell’amministrazione viene analogamente registrato.
I compiti attribuiti all’amministratore di sostegno possono avere natura patrimoniale o personale.
Nel primo caso, rientrano tra le sue mansioni attività quali la gestione del conto corrente, il pagamento delle utenze domestiche o la riscossione della pensione.
Nel secondo caso, i compiti riguardano la tutela della salute fisica e psichica del beneficiario e la cura generale della sua persona. L’amministratore può agire in due modalità: come assistente, affiancando il beneficiario nello svolgimento di specifici atti, o come rappresentante, sostituendolo nel compimento di determinate attività, in base a quanto disposto dal decreto di nomina.
L’amministratore di sostegno deve informare il beneficiario delle decisioni che intende adottare e, in caso di disaccordo, è tenuto a riportare la questione al giudice tutelare per un’eventuale revisione delle disposizioni. Il rapporto di fiducia tra amministratore e beneficiario è centrale per l’efficace esecuzione del mandato e per garantire che i diritti e gli interessi della persona vulnerabile siano rispettati in ogni fase. L’incarico può essere revocato qualora vengano meno i presupposti della misura o si riscontri l’inadeguatezza dell’amministrazione a soddisfare le esigenze del beneficiario.
Rendiconto e sostituzione dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno, indipendentemente dalla durata del suo incarico, è tenuto a rendere conto del proprio operato al giudice tutelare con cadenza annuale o secondo le tempistiche stabilite dal decreto di nomina. Questo adempimento è fondamentale per garantire la trasparenza nella gestione delle risorse del beneficiario e per assicurare che l’amministrazione sia svolta nell’interesse esclusivo della persona tutelata.
Il rendiconto deve includere una relazione dettagliata sulle condizioni di vita e salute del beneficiario, nonché un resoconto delle attività economiche svolte nell’esercizio dell’incarico. Tra i documenti da allegare figurano gli estratti conto bancari o postali e i giustificativi delle spese sostenute, come fatture, ricevute e buste paga. Per agevolare la procedura, è spesso richiesto l’uso di moduli standard predisposti dagli uffici giudiziari, da compilare con attenzione e seguendo le istruzioni fornite.
La sostituzione dell’amministratore di sostegno può avvenire in diverse circostanze. Nei casi di morte, assenza o scomparsa dell’amministratore, il giudice provvede a nominare un nuovo soggetto idoneo a ricoprire l’incarico.
Inoltre, l’amministratore può richiedere di essere esonerato qualora l’incarico si riveli eccessivamente gravoso e vi sia un altro soggetto idoneo a subentrare. In situazioni di inadempienza o abuso, il giudice tutelare ha il potere di revocare l’incarico e di procedere alla nomina di un nuovo amministratore, al fine di garantire una gestione appropriata e conforme agli interessi del beneficiario.
Atti per cui l’amministratore di sostegno deve essere autorizzato
L’amministratore di sostegno, pur avendo poteri specifici conferiti dal decreto di nomina, deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione o che possono incidere significativamente sul patrimonio o sui diritti del beneficiario. Questa misura garantisce che le decisioni più rilevanti siano adottate con la supervisione dell’autorità giudiziaria, tutelando al massimo gli interessi della persona assistita.
L’amministratore di sostegno è tenuto a chiedere al Giudice Tutelare l’autorizzazione per:
- ampliare i poteri del suo incarico;
- sostenere spese superiori a quelle autorizzate dal decreto;
- compiere atti di straordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l’autorizzazione comprendono, ad esempio, i seguenti:
- acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni;
- accettazione di eredità o rinunzia all’eredità; accettazione di donazioni;
- sottoscrizione di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni;
- promozione di azioni giudiziarie;
- vendita di beni immobili e mobili registrati;
- costituzione di pegni o ipoteche;
- divisioni o promozione dei relativi giudizi;
- stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati;
- ogni altro atto che ecceda i limiti che il G.T. ha fissato nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno
In ogni caso, il giudice tutelare valuta con attenzione le richieste di autorizzazione presentate dall’amministratore di sostegno, considerando l’effettiva necessità dell’atto proposto e il suo impatto sugli interessi e sul patrimonio del beneficiario. L’autorizzazione viene concessa solo qualora l’atto sia ritenuto indispensabile o comunque vantaggioso per il beneficiario.
Il nostro Studio Legale è a disposizione per fornire assistenza qualificata a chiunque necessiti di supporto nella nomina di un amministratore di sostegno, offrendo un servizio personalizzato e conforme alle specifiche esigenze del caso. Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza, vi invitiamo a contattarci. Saremo lieti di affiancarvi con la nostra esperienza e professionalità.
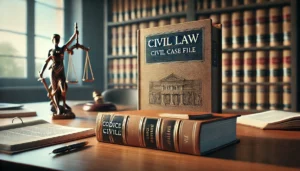
Diritto Civile: consulenza legale su contratti, capacità delle persone, e diritti civili presso lo Studio Legale Luca D’Agostino a Roma.

da Redazione | Gen 14, 2025 | Diritto d'Impresa
Il Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act) rappresenta un punto di svolta per il settore finanziario europeo, introducendo un quadro normativo armonizzato per la gestione del rischio ICT e la resilienza operativa digitale. L’obiettivo principale della normativa è rafforzare la capacità delle entità finanziarie di prevenire, rilevare e rispondere a eventi che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati e la continuità operativa. Per una sintesi delle disposizioni del Regolamento, rinviamo a un nostro precedente approfondimento.
La Banca d’Italia, attraverso la comunicazione pubblicata il 23 dicembre 2024, ha richiamato l’attenzione degli intermediari vigilati sull’importanza di conformarsi a tali disposizioni e di intraprendere un’accurata analisi dei rischi DORA, obbligatoria per tutti i soggetti destinatari. La comunicazione è destinata ai seguenti soggetti vigilati da Banca d’Italia: banche, imprese di investimento, gestori, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, emittenti di token collegati ad attività, prestatori di servizi per le cripto-attività, fornitori di servizi di crowdfunding. Qui il testo della comunicazione.
Ricordiamo che a partire dal 17 gennaio 2025, il Regolamento DORA sarà pienamente applicabile, imponendo obblighi stringenti in materia di gestione dei rischi informatici e sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).
La normativa si integra con il Regolamento attuativo UE 2024/1774, che disciplina in dettaglio le modalità di implementazione delle politiche e dei protocolli per il presidio del rischio ICT. In questo contesto, l’analisi dei rischi DORA assume un ruolo centrale per garantire non solo la conformità normativa, ma anche la resilienza complessiva del sistema finanziario, ormai sempre più esposto a minacce cibernetiche e vulnerabilità sistemiche.
La comunicazione della Banca d’Italia ha inoltre fissato al 30 aprile 2025 la scadenza per la trasmissione dell’autovalutazione da parte degli intermediari finanziari. Questo documento, che dovrà essere approvato dall’organo di amministrazione, rappresenta un passaggio essenziale per verificare che le politiche, i protocolli e le pratiche interne siano pienamente in linea con i requisiti stabiliti dal Regolamento DORA.
L’urgenza di predisporre tale autovalutazione impone agli intermediari una pianificazione immediata delle attività necessarie per adempiere agli obblighi previsti, assicurando che le misure adottate siano adeguate a prevenire, controllare e mitigare i rischi ICT.
Analisi dei rischi DORA: obblighi per gli intermediari vigilati
Il Regolamento DORA, insieme al Regolamento attuativo UE 2024/1774, stabilisce un quadro normativo dettagliato che vincola gli intermediari finanziari a implementare una gestione del rischio ICT organica e integrata.
La Comunicazione della Banca d’Italia pubblicata il 23 dicembre 2024 evidenzia come tali obblighi si articolino in una serie di requisiti stringenti, che impongono agli intermediari di adattare le loro politiche e procedure interne per fronteggiare le crescenti minacce alla sicurezza informatica. Al centro di questo quadro si colloca l’analisi dei rischi DORA, che rappresenta un presupposto fondamentale per assicurare la compliance a tale normativa.
Il Regolamento prevede che ogni intermediario adotti un sistema di gestione dei rischi ICT strutturato, che comprenda politiche e protocolli volti a prevenire, rilevare e mitigare le vulnerabilità cibernetiche.
In particolare, è richiesto che vengano implementati presidi efficaci per la protezione della confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati. Tale sistema deve essere integrato con strumenti di monitoraggio continuo delle attività anomale, in modo da rilevare tempestivamente eventi che possano compromettere i servizi offerti.
La Banca d’Italia, richiamando le evidenze delle sue analisi di supervisione, sottolinea che gli incidenti cibernetici più frequenti sono causati da accessi non autorizzati e da inadeguatezze nei processi di modifica dei sistemi ICT, i quali richiedono un controllo particolarmente rigoroso.
Gli obblighi di compliance includono anche la necessità di adottare strategie specifiche per la gestione dei rischi derivanti da terze parti. I fornitori di servizi TIC rappresentano un punto critico per la sicurezza degli intermediari, e il Regolamento impone che i contratti con tali soggetti siano conformi a standard di sicurezza elevati.
Un ulteriore aspetto evidenziato nella Comunicazione della Banca d’Italia riguarda l’adattamento delle politiche interne degli intermediari. Queste devono essere allineate alle disposizioni del Regolamento DORA e del Regolamento attuativo UE 2024/1774, garantendo che ogni decisione strategica sia supportata da dati accurati e da un’analisi del rischio ben fondata.
La carenza di sistemi di aggregazione e reportistica dei dati sui rischi, come emerso dalle analisi di supervisione, può infatti compromettere la solidità del processo decisionale e minare la capacità dell’ente di fronteggiare le minacce informatiche.
Analisi dei rischi DORA: il ruolo dell’autovalutazione nella gestione dei rischi ICT
L’autovalutazione è uno step fondamentale nell’implementazione delle disposizioni previste dal Regolamento DORA e dal Regolamento attuativo UE 2024/1774. La Comunicazione della Banca d’Italia sottolinea la necessità che tutti gli intermediari vigilati, su base consolidata o individuale, conducano un’analisi approfondita della loro capacità di gestione dei rischi ICT, valutando in che misura le loro politiche e i loro protocolli siano conformi ai requisiti normativi.
Questo processo, che culmina con l’approvazione da parte dell’organo di amministrazione, non è solo un obbligo formale, ma uno strumento strategico per garantire la resilienza operativa e la continuità aziendale.
La analisi dei rischi DORA richiede agli intermediari di esaminare attentamente vari aspetti delle loro operazioni. Tra questi, le strategie di gestione del rischio di terza parte rivestono un ruolo prioritario. Gli intermediari devono valutare l’adeguatezza dei contratti stipulati con i fornitori di servizi TIC e verificare che le clausole contrattuali prevedano standard di sicurezza in linea con le disposizioni del Regolamento. Inoltre, è fondamentale che siano messe in atto misure di monitoraggio per garantire che i fornitori rispettino tali standard nel tempo.
Un’altra area critica riguarda i programmi di test di resilienza operativa digitale. Questi test, che devono essere svolti regolarmente, mirano a verificare la capacità dell’intermediario di affrontare incidenti operativi o cibernetici, prevenire la compromissione dei sistemi e proteggere la riservatezza dei dati. L’analisi dei rischi DORA richiede che tali test siano progettati in modo da coprire tutti gli aspetti operativi critici, compresi i processi interni, i sistemi TIC e le relazioni con i fornitori terzi.
La Banca d’Italia sottolinea, inoltre, l’importanza di un efficace ICT change management, in quanto i cambiamenti non adeguatamente gestiti rappresentano una delle principali cause di incidenti operativi. Gli intermediari devono quindi valutare che i propri processi di gestione delle modifiche siano coerenti con i requisiti del Regolamento DORA, includendo politiche specifiche, attribuzioni di responsabilità e meccanismi di controllo.
L’autovalutazione deve coinvolgere tutte le funzioni di controllo interne, sia di secondo che di terzo livello, garantendo un approccio trasversale alla gestione del rischio ICT.
Questo processo non solo consente agli intermediari di identificare eventuali lacune, ma offre anche l’opportunità di sviluppare un sistema di gestione dei rischi che sia proattivo e dinamico.
Analisi dei rischi DORA: impatti della normativa sulla governance aziendale
L’analisi dei rischi DORA non si limita a rafforzare la resilienza operativa degli intermediari finanziari, ma incide profondamente sulla loro governance aziendale. Il Regolamento DORA e il Regolamento delegato UE 2024/1774 attribuiscono agli organi di amministrazione un ruolo centrale nella gestione dei rischi ICT, imponendo loro di approvare e supervisionare le strategie, le politiche e le procedure necessarie per garantire la conformità normativa e la continuità operativa.
Questa responsabilità non è semplicemente tecnica, ma si estende a un livello strategico che coinvolge l’intero assetto decisionale dell’organizzazione.
La Comunicazione della Banca d’Italia evidenzia come gli organi di amministrazione siano chiamati a garantire un controllo efficace e a promuovere una cultura aziendale orientata alla gestione proattiva del rischio ICT. L’approvazione dell’autovalutazione, che rappresenta uno degli elementi cardine dell’analisi dei rischi DORA, richiede un coinvolgimento diretto delle funzioni apicali, che devono essere adeguatamente informate e formate sui requisiti della normativa. Questo passaggio implica non solo la validazione dei processi esistenti, ma anche la definizione di linee guida per affrontare le criticità emerse durante l’autovalutazione.
Un aspetto fondamentale è la responsabilità degli organi di governance nella gestione del rischio di terza parte, in particolare nei confronti dei fornitori di servizi TIC. Gli intermediari devono assicurarsi che le strategie di gestione delle terze parti siano integrate nel sistema di governance e che le relazioni contrattuali includano clausole specifiche per la sicurezza ICT.
Gli organi di amministrazione devono inoltre monitorare regolarmente l’operato dei fornitori, verificando che rispettino gli standard richiesti dal Regolamento DORA e adottando misure correttive in caso di non conformità.
L’analisi dei rischi DORA influenza anche la capacità degli organi di amministrazione di prendere decisioni basate su dati accurati e aggiornati. La capacità di aggregare e analizzare i dati sui rischi ICT, come evidenziato dalle indagini della Banca d’Italia, è essenziale per supportare il processo decisionale e garantire una gestione efficace dei rischi.
La mancata implementazione di sistemi adeguati per la raccolta e l’analisi dei dati può compromettere la solidità della governance e aumentare la vulnerabilità dell’organizzazione a incidenti operativi e cibernetici.
Infine, il Regolamento DORA richiede che gli organi di amministrazione adottino un approccio dinamico alla gestione del rischio, in grado di adattarsi alle continue evoluzioni del panorama tecnologico e normativo. Questo include la promozione di programmi di formazione interna, lo sviluppo di strumenti per il monitoraggio continuo dei rischi e la creazione di protocolli per la gestione delle crisi.
La governance aziendale, in questo contesto, diventa il fulcro attorno al quale ruota l’intera strategia di conformità al Regolamento DORA, garantendo non solo la protezione delle operazioni, ma anche la fiducia degli stakeholders.
Conclusioni: un approccio strategico per l’analisi dei rischi DORA
L’analisi dei rischi DORA rappresenta un passaggio obbligato per tutte le entità finanziarie soggette al Regolamento DORA. La scadenza del 30 aprile 2025 per la trasmissione dell’autovalutazione alla Banca d’Italia richiede un approccio strategico e tempestivo, orientato non solo a garantire la conformità normativa, ma anche a rafforzare la resilienza operativa e la sicurezza dell’intero sistema finanziario.
Gli obblighi imposti dalla normativa, che spaziano dalla gestione del rischio ICT all’implementazione di test di resilienza operativa digitale, evidenziano la necessità di una pianificazione accurata e di un coinvolgimento diretto degli organi di governance.
Il quadro normativo delineato dal Regolamento DORA impone agli intermediari di adottare misure che non solo prevengano e rilevino le minacce informatiche, ma che consentano anche di rispondere in modo efficace alle criticità. La gestione del rischio di terza parte, l’adattamento delle politiche interne e l’implementazione di sistemi di monitoraggio continuo sono solo alcune delle sfide che gli intermediari devono affrontare. Allo stesso tempo, l’autovalutazione rappresenta un’opportunità per individuare aree di miglioramento e per rafforzare la capacità dell’organizzazione di affrontare un panorama di rischi in continua evoluzione.
La governance aziendale svolge un ruolo fondamentale in questo contesto, fungendo da motore per la conformità e la resilienza nel quadro dell’analisi dei rischi DORA. Gli organi di amministrazione non solo devono approvare l’autovalutazione, ma anche guidare l’intera organizzazione verso l’adozione di un sistema di gestione dei rischi che sia dinamico e allineato alle evoluzioni tecnologiche e normative.
La capacità di adattarsi rapidamente e di anticipare le minacce rappresenta un vantaggio competitivo per le entità finanziarie che operano in un contesto sempre più digitalizzato e interconnesso.
In questo scenario complesso, lo Studio si rende disponibile per fornire chiarimenti e consulenza sulle strategie di conformità al Regolamento DORA e a organizzare percorsi di formazione specifici per gli apicali dell’intermediario o dei suoi fornitori.

Analisi dei rischi DORA nel settore finanziario. Studio legale D’agostino a Roma, con expertise specifica in ambito corporate compliance e cyber security.
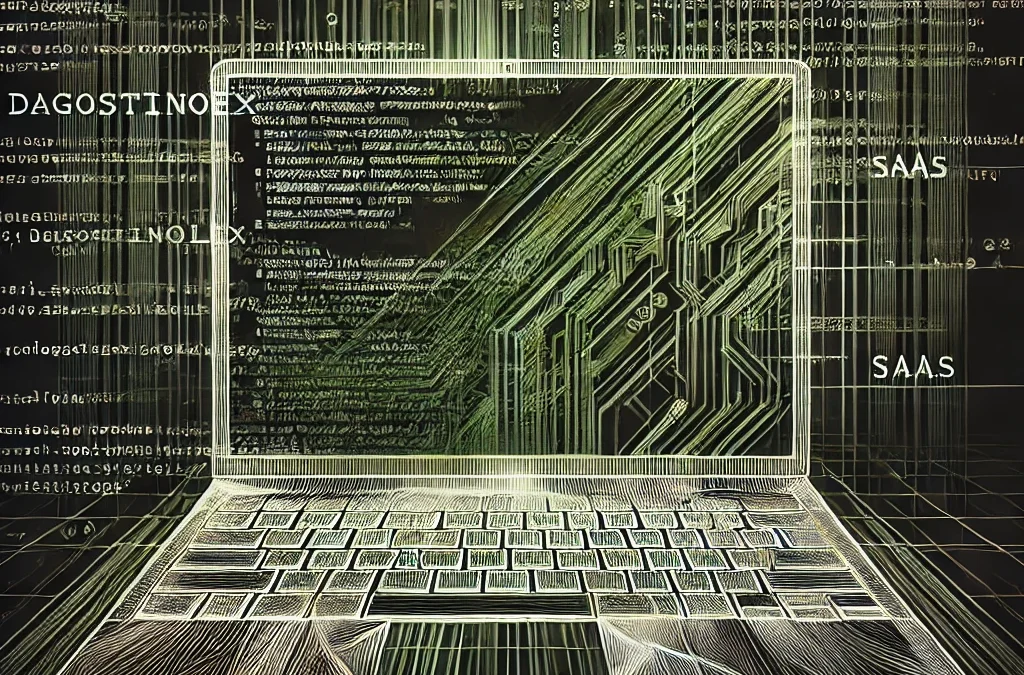
da Redazione | Gen 9, 2025 | Diritto d'Impresa
Il Contratto di licenza in SaaS rappresenta uno strumento giuridico di fondamentale importanza per regolare l’utilizzo del software fornito in modalità Software-as-a-Service. Questo tipo di contratto, sempre più diffuso nel panorama tecnologico delle start-up, si distingue per la sua funzione di disciplinare il rapporto tra il Licenziante, titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul software, e il Licenziatario, ovvero l’utente autorizzato a fruirne.
Nel contesto del SaaS, il software non viene ceduto in proprietà, ma è reso disponibile per l’utilizzo remoto, su base contrattuale e per un periodo determinato. La centralità del Contratto di licenza in SaaS risiede nella sua capacità di tutelare adeguatamente i diritti del Licenziante, garantendo al contempo al Licenziatario un utilizzo conforme e sicuro.
Uno degli aspetti più critici riguarda la tutela della proprietà intellettuale dello sviluppatore, che deve essere garantita attraverso clausole precise e rigorose. Il contratto deve infatti prevenire l’utilizzo non autorizzato del software, proteggere il codice sorgente da eventuali tentativi di decompilazione o modifica e limitare la possibilità di condivisione impropria con soggetti terzi. In Italia esistono, invero, regole specifiche e anche limitazioni alla brevettabilità del Software.
La definizione di queste clausole è essenziale per evitare abusi e per salvaguardare le tecniche e gli algoritmi sottesi al funzionamento del software, che rappresentano il cuore del know-how aziendale.
Parallelamente, il Contratto di licenza in SaaS deve tener conto delle esigenze del Licenziatario, il quale necessita di chiare indicazioni circa i propri diritti e i limiti all’uso del software. Questo equilibrio tra tutela del Licenziante e garanzia di un uso lecito da parte del Licenziatario rappresenta uno degli elementi distintivi di un contratto ben redatto.
Nel presente articolo verranno esaminati gli elementi fondamentali di un Contratto di licenza in SaaS, con particolare attenzione alle clausole volte a tutelare la proprietà intellettuale, garantendo il rispetto delle normative applicabili e la protezione del patrimonio tecnologico del Licenziante.
Le definizioni nel Contratto di Licenza in SaaS: elementi essenziali
Nel Contratto di licenza in SaaS, la sezione dedicata alle definizioni è una componente essenziale per stabilire con chiarezza i termini tecnici e giuridici che ricorrono nel testo contrattuale. Questa parte iniziale del contratto non ha una funzione meramente descrittiva, ma costituisce il fondamento per l’interpretazione uniforme delle clausole da parte delle parti contraenti. La precisione e la completezza di questa sezione sono fondamentali per evitare incomprensioni o contenziosi futuri.
Tra le definizioni più rilevanti in un Contratto di licenza in SaaS, emerge il termine “Software”, inteso come l’insieme organizzato e strutturato di istruzioni capace di svolgere operazioni specifiche su un sistema elettronico. È cruciale specificare che l’accesso al Software, in modalità SaaS, non implica la cessione di proprietà del programma, bensì il diritto limitato al suo utilizzo per finalità ben definite. A ciò si aggiunge il “Codice sorgente”, che rappresenta il linguaggio di programmazione con cui il software è stato sviluppato. La sua protezione è un elemento centrale, in quanto consente di preservare il know-how tecnologico e gli algoritmi proprietari del Licenziante, escludendo qualsiasi tentativo di decompilazione o modifica non autorizzata.
Altro termine essenziale è “Regime SaaS”, che definisce la modalità di erogazione del servizio. In questo contesto, il Software è reso disponibile per l’utilizzo remoto tramite un’infrastruttura cloud, senza che vi sia necessità di installazione su dispositivi locali. Ciò comporta importanti implicazioni in termini di accesso, sicurezza e aggiornamento, che devono essere regolamentate nel contratto.
Di rilievo sono anche le “Informazioni riservate”, che includono dati tecnici, operativi o strategici del Licenziante e del Licenziatario. Tali informazioni, se divulgate, potrebbero pregiudicare le aspettative economiche o la competitività delle parti, e pertanto il contratto prevede specifici obblighi di riservatezza. Nel contesto di un Contratto di licenza in SaaS, questi dati comprendono anche quelli generati dal Software, come i risultati di analisi e i dati elaborati in modalità automatizzata, la cui titolarità deve essere chiaramente attribuita.
Ulteriori definizioni significative includono i “Profili di utilizzo”, che distinguono tra diverse configurazioni del Software (ad esempio, base, avanzato o business) in relazione alle funzionalità e al numero di copie autorizzate. Allo stesso modo, il termine “Progetti” identifica l’ampiezza e il dettaglio delle funzionalità o delle facoltà attribuire in licenza Software, eventualmente specificati nella scheda tecnica. Tali definizioni non solo delimitano l’oggetto del contratto, ma consentono al Licenziante di strutturare un’offerta modulare e scalabile, adattabile alle diverse esigenze dei Licenziatari.
La completezza della sezione dedicata alle definizioni in un Contratto di licenza in SaaS non è solo un esercizio di formalismo, ma una necessità per assicurare trasparenza, chiarezza e tutela delle parti. Ogni termine deve essere calibrato con attenzione, affinché i diritti e gli obblighi contrattuali risultino inequivocabili e coerenti con la normativa vigente.
La licenza d’uso nel Contratto di Licenza in SaaS: diritti e limitazioni
La clausola relativa alla licenza d’uso rappresenta il cuore del Contratto di licenza in SaaS, in quanto stabilisce i termini entro cui il Licenziatario è autorizzato a utilizzare il software. A differenza di altre tipologie di licenze, nel modello SaaS l’utente non acquisisce alcun diritto di proprietà sul software, ma ottiene una semplice autorizzazione all’uso, circoscritta dalle condizioni contrattuali.
Questa impostazione consente al Licenziante di mantenere il pieno controllo sulla propria opera intellettuale, preservandone la titolarità e limitandone l’utilizzo a quanto espressamente pattuito.
Un elemento essenziale della licenza è la sua non esclusività, che permette al Licenziante di concedere il medesimo software ad altri utenti, massimizzando così il rendimento economico del prodotto. La licenza è inoltre non trasferibile, impedendo al Licenziatario di cedere a terzi i diritti d’uso senza l’esplicito consenso del Licenziante. Questa previsione tutela il Licenziante da eventuali violazioni delle clausole contrattuali, garantendo che l’uso del software avvenga solo da parte dei soggetti autorizzati.
La clausola deve inoltre specificare le limitazioni d’uso, fondamentali per prevenire abusi. Nel Contratto di licenza in SaaS, ciò si traduce spesso nel divieto di alterare, decompilare, o effettuare operazioni di reverse engineering sul software. Queste limitazioni proteggono il codice sorgente, che costituisce l’elemento più prezioso del prodotto, essendo il risultato di un complesso processo creativo e tecnologico. L’utilizzo del software è poi vincolato a un determinato numero di utenti o sedi aziendali, come stabilito dal profilo acquistato e descritto nel modulo d’ordine o nella scheda tecnica.
Un altro aspetto rilevante è la durata della licenza, che deve essere chiaramente definita nel contratto. Il Contratto di licenza in SaaS prevede generalmente una validità limitata, spesso su base mensile o annuale, con la possibilità di rinnovo. Al termine del periodo stabilito, il Licenziatario deve cessare l’utilizzo del software, a meno che non sia previsto un rinnovo o un’estensione concordata.
Infine, la clausola di licenza deve disciplinare il comportamento del Licenziatario in caso di malfunzionamenti del software. È comune prevedere l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali difetti al Licenziante, vietando al Licenziatario di apportare modifiche al codice sorgente. Questo garantisce che la proprietà intellettuale resti integra e che eventuali problemi tecnici vengano gestiti esclusivamente dal Licenziante o dai suoi delegati.
In buona sostanza, in un Contratto di licenza in SaaS, una clausola di licenza d’uso ben redatta è fondamentale per proteggere gli interessi del Licenziante, regolando in modo chiaro e dettagliato i diritti e i limiti concessi al Licenziatario. Ciò assicura che il software venga utilizzato conformemente alle finalità previste e nel rispetto della proprietà intellettuale del Licenziante.
Proprietà del software e diritti di proprietà intellettuale nel Contratto di Licenza in SaaS
Nel Contratto di licenza in SaaS, la clausola relativa alla proprietà del software e ai diritti di proprietà intellettuale svolge un ruolo cruciale nella tutela del know-how tecnologico e creativo del Licenziante. Questa clausola mira a preservare il valore economico e strategico del software, garantendo che il Licenziatario non possa avanzare alcuna pretesa sui diritti di proprietà né compiere attività che possano compromettere l’integrità del prodotto.
Il contratto stabilisce in modo inequivocabile che il Licenziante detiene la titolarità esclusiva del software, inclusi il codice sorgente, gli algoritmi e ogni altra componente tecnica o creativa che ne costituisce la struttura. Tale titolarità si estende anche alle eventuali implementazioni, migliorie o aggiornamenti del software, che rimangono di proprietà esclusiva del Licenziante, anche qualora siano sviluppati in risposta a specifiche esigenze del Licenziatario. In questo modo, il Contratto di licenza in SaaS previene qualsiasi ambiguità circa la paternità intellettuale delle innovazioni tecnologiche.
Un elemento particolarmente rilevante è la protezione del codice sorgente, il quale rappresenta il cuore del software e il risultato di un processo creativo e tecnico altamente specializzato. Il contratto vieta espressamente al Licenziatario di accedere, modificare o effettuare operazioni di reverse engineering sul codice sorgente, configurando tali azioni come violazioni contrattuali gravi. Inoltre, ogni tentativo di riprodurre, copiare o alterare il software è considerato un atto di concorrenza sleale e può dar luogo a conseguenze legali, incluso il risarcimento dei danni.
La clausola sulla proprietà intellettuale include anche disposizioni relative ai risultati di analisi generati dal software durante il suo utilizzo. Questi output, che possono includere dati aggregati, suggerimenti o report, sono spesso utilizzabili liberamente dal Licenziatario per finalità aziendali. Tuttavia, i processi di apprendimento automatico e le informazioni generate dall’interazione degli utenti con il software rimangono di esclusiva proprietà del Licenziante. Questa distinzione consente al Licenziante di valorizzare ulteriormente il proprio prodotto, integrando le conoscenze acquisite per migliorare le funzionalità future.
Un ulteriore aspetto riguarda i marchi e gli altri segni distintivi apposti sul software e sulla documentazione correlata. Il contratto chiarisce che tali elementi rimangono di proprietà esclusiva del Licenziante e non possono essere alterati, rimossi o utilizzati dal Licenziatario per finalità non autorizzate. Questa previsione è fondamentale per proteggere l’identità commerciale del Licenziante e preservare la riconoscibilità del prodotto sul mercato.
Sicurezza dei dati e obblighi di riservatezza nel Contratto di Licenza in SaaS
Nel Contratto di licenza in SaaS, la sicurezza dei dati e la riservatezza costituiscono elementi di primaria importanza, poiché l’erogazione del software in modalità SaaS comporta l’elaborazione, la conservazione e il trattamento di informazioni sensibili, sia del Licenziante sia del Licenziatario. Tali obblighi trovano fondamento non solo nel contratto, ma anche nelle normative applicabili, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali.
Una clausola ben strutturata deve innanzitutto definire il concetto di “Informazioni riservate”, includendo ogni dato tecnico, commerciale o operativo relativo al software o all’azienda del Licenziante e del Licenziatario, nonché i dati personali trattati durante l’utilizzo del software. Il contratto stabilisce che tali informazioni non possono essere divulgate o utilizzate per finalità non previste, imponendo a entrambe le parti un obbligo di custodia e protezione. Questo obbligo si estende anche ai dati generati dal software, come i report e i risultati di analisi, che, pur essendo utilizzabili dal Licenziatario, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative.
Il Contratto di licenza in SaaS include tipicamente disposizioni dettagliate sulle misure di sicurezza che il Licenziatario deve adottare per proteggere l’accesso al software. Tra queste figurano la custodia delle credenziali di accesso, la limitazione dell’utilizzo ai soli utenti autorizzati e l’adozione di protocolli tecnici e organizzativi per prevenire accessi non autorizzati o violazioni.
Il Licenziante, dal canto suo, è responsabile di garantire che il software sia progettato e mantenuto in conformità agli standard di sicurezza più elevati, prevenendo rischi di data breach o perdita di informazioni.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda il trattamento dei dati personali. Nel modello SaaS, il Licenziatario agisce spesso come titolare del trattamento, stabilendo le finalità e i mezzi del trattamento stesso, mentre il Licenziante funge da responsabile del trattamento, garantendo che i dati siano gestiti nel rispetto delle istruzioni contrattuali e delle normative vigenti.
Questa distinzione deve essere chiaramente esplicitata nel contratto, che può includere una specifica Data Processing Agreement (DPA) come allegato, per regolamentare in modo dettagliato i diritti e gli obblighi delle parti in materia di protezione dei dati personali.
Un’altra clausola essenziale riguarda l’obbligo di notificare eventuali violazioni dei dati personali (data breach). Il contratto deve prevedere che il Licenziante informi tempestivamente il Licenziatario in caso di incidente di sicurezza, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare l’impatto e adottare misure correttive. Tale obbligo si estende anche alle notifiche verso le autorità competenti, come il Garante per la protezione dei dati personali, nei casi previsti dalla normativa.
In conclusione, le clausole sulla sicurezza dei dati e sulla riservatezza sono essenziali in ogni Contratto di licenza in SaaS. Esse non solo proteggono le informazioni sensibili e i dati personali delle parti, ma garantiscono anche la conformità alle normative applicabili, riducendo i rischi legali e reputazionali associati a eventuali violazioni. La redazione accurata di queste clausole richiede competenze specifiche in materia di diritto della privacy e sicurezza informatica, assicurando una tutela completa per tutte le parti coinvolte.
Clausole di manleva e limitazioni di responsabilità nel Contratto di Licenza in SaaS
Le clausole di manleva e di limitazione di responsabilità rappresentano una componente essenziale del Contratto di licenza in SaaS, poiché mirano a bilanciare i rischi derivanti dall’utilizzo del software e a proteggere le parti da rivendicazioni e danni che potrebbero insorgere nel corso del rapporto contrattuale. Tali disposizioni, se ben strutturate, offrono una tutela significativa sia al Licenziante che al Licenziatario, evitando oneri sproporzionati o responsabilità impreviste.
La clausola di manleva stabilisce che una delle parti, solitamente il Licenziatario, si impegna a risarcire l’altra parte per eventuali danni, costi o spese derivanti da violazioni contrattuali o comportamenti illeciti. Nel caso del Contratto di licenza in SaaS, il Licenziatario può essere chiamato a manlevare il Licenziante rispetto a rivendicazioni di terzi connesse all’uso improprio del software o alla violazione di diritti di proprietà intellettuale. Ad esempio, qualora il Licenziatario utilizzi il software per elaborare dati che violano i diritti di terzi o norme di legge, sarà tenuto a indennizzare il Licenziante per i danni subiti, incluse eventuali spese legali. Questa clausola è particolarmente rilevante in contesti in cui il software gestisce dati sensibili o opera in settori regolamentati.
La clausola di limitazione di responsabilità, invece, definisce i confini entro cui il Licenziante è responsabile per eventuali danni derivanti dall’utilizzo del software. Nel Contratto di licenza in SaaS, il Licenziante solitamente declina ogni responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come la perdita di profitti, l’interruzione dell’attività o il deterioramento dei dati. Inoltre, il Licenziante non può essere ritenuto responsabile per disservizi derivanti da fattori esterni, come problemi di connettività Internet, malfunzionamenti dell’hardware del Licenziatario o attacchi informatici non riconducibili a proprie omissioni. È altresì comune escludere la responsabilità per i risultati ottenuti dall’utilizzo del software, specificando che quest’ultimo è fornito “così com’è” e “come disponibile”.
Un aspetto particolarmente rilevante in questo contesto è l’esclusione di responsabilità per eventi di forza maggiore, quali disastri naturali, attacchi informatici su larga scala o altre circostanze al di fuori del controllo del Licenziante. Tali eventi, se adeguatamente definiti nel contratto, sollevano il Licenziante dall’obbligo di fornire il servizio o di risarcire i danni derivanti dalla mancata esecuzione delle proprie prestazioni.
Queste clausole, pur essendo a vantaggio del Licenziante, devono essere redatte con equilibrio, tenendo conto dei diritti del Licenziatario e della necessità di evitare squilibri contrattuali. Il contratto può prevedere, ad esempio, che il Licenziante garantisca la risoluzione tempestiva di eventuali difetti o malfunzionamenti del software, evitando così che le limitazioni di responsabilità si traducano in un’esclusione totale degli obblighi contrattuali.
In sintesi, le clausole di manleva e di limitazione di responsabilità nel Contratto di licenza in SaaS sono strumenti indispensabili per gestire i rischi associati all’erogazione del servizio. Esse devono essere redatte con attenzione e precisione, assicurando un equilibrio tra la tutela del Licenziante e la protezione degli interessi del Licenziatario, in modo da garantire un rapporto contrattuale equo e conforme alle normative vigenti.
Assistenza legale nella redazione del Contratto di Licenza in SaaS: rivolgiti a un avvocato per la tutela dei tuoi diritti
Il Contratto di licenza in SaaS rappresenta uno strumento imprescindibile per regolamentare i rapporti tra Licenziante e Licenziatario, assicurando al primo la protezione della propria proprietà intellettuale e al secondo un utilizzo conforme del software.
Dalle definizioni ai diritti di utilizzo, dalla sicurezza dei dati alle limitazioni di responsabilità, ogni elemento del contratto concorre a creare un quadro giuridico equilibrato, in grado di tutelare sia gli interessi economici del Licenziante che le legittime aspettative del Licenziatario.
Affinché il contratto sia efficace, è fondamentale che venga redatto da professionisti esperti, in grado di adattare le clausole alle specifiche esigenze del settore tecnologico e alle peculiarità del prodotto offerto. La nostra expertise ci consente di supportare sviluppatori e start-up digitali nella creazione di Contratti di licenza in SaaS che proteggano adeguatamente la loro proprietà intellettuale e il loro business. Inoltre, forniamo assistenza nella redazione di privacy policy e di altra documentazione contrattuale indispensabile per assicurare il rispetto delle normative e per garantire un rapporto solido e trasparente con gli utenti.
Il nostro Studio legale è specializzato nella consulenza per imprese digitali e sviluppatori software, offrendo soluzioni su misura per la tutela dei diritti del Licenziante. Per chi opera nel settore tecnologico, la protezione del proprio patrimonio intellettuale e la conformità normativa sono fattori chiave per il successo e la sostenibilità del business.

Il nostro studio legale offre supporto strategico e consulenza personalizzata per startup e business digitali, garantendo una crescita sicura e conforme alle normative del settore. Confrontati con noi per mettere a punto un Contratto di licenza in SaaS efficace.

da Redazione | Dic 28, 2024 | Notizie e Aggiornamenti Legislativi
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 di riforma del Codice della Strada (CdS) segna un cambiamento significativo nell’ambito della circolazione stradale, introducendo nuove disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità degli utenti della strada. Questo intervento legislativo, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, mira a rafforzare il sistema sanzionatorio e a promuovere un approccio più rigoroso alla disciplina della circolazione stradale.
Abbiamo esaminato nello specifico le nuove disposizioni concernenti la disciplina della guida in stato d’ebbrezza da alcol o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in un precedente articolo; in questa sede si occuperemo di dare uno sguardo alle altre novità introdotte nel Codice della Strada (CdS) dalla Legge 177/2024.
L’intero impianto normativo si fonda su un concetto chiave: incrementare il livello di sicurezza sulle strade italiane mediante strumenti più efficaci e sanzioni più incisive. In particolare, le modifiche al CdS intervengono su una vasta gamma di aspetti, che spaziano dalle nuove regole per i neopatentati, fino a discipline specifiche per le violazioni commesse in ZTL o per eccessi di velocità, o relative all’utilizzo dei monopattini elettrici.
Nuove sanzioni per il superamento dei limiti di velocità nel Codice della Strada (CdS)
La riforma del Codice della Strada (CdS) introdotta con la Legge 25 novembre 2024 n. 177, ha apportato modifiche importanti anche al regime sanzionatorio per il superamento dei limiti di velocità, inasprendo le pene per chi commette queste violazioni. Tali modifiche riflettono la volontà del legislatore di adottare un approccio più severo, soprattutto nei casi di infrazioni reiterate o commesse in contesti particolarmente sensibili, come i centri abitati.
Per chi supera i limiti di velocità, le sanzioni amministrative pecuniarie restano proporzionate all’entità dell’infrazione, ma con alcune novità. Le multe per il superamento di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h restano comprese tra 173 e 694 euro, mentre per il superamento di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h si va da 544 a 2.174 euro, con la sospensione della patente da uno a tre mesi. La violazione più grave, ossia il superamento di oltre 60 km/h, comporta una sanzione tra 847 e 3.389 euro, oltre alla sospensione della patente da sei a dodici mesi.
Un’aggiunta rilevante riguarda i casi di violazioni reiterate all’interno dei centri abitati. La riforma al CdS prevede che il superamento dei limiti di velocità per almeno due volte in un anno, in queste aree, possa comportare la sospensione della patente da 15 a 30 giorni, in aggiunta alla sanzione pecuniaria. Questo inasprimento sottolinea l’attenzione verso la protezione degli utenti più vulnerabili, come pedoni e ciclisti, che frequentano maggiormente gli spazi urbani.
La modifica più innovativa riguarda il trattamento delle infrazioni multiple rilevate in un breve periodo. Con l’introduzione del comma 6-ter nell’articolo 142, il legislatore ha stabilito che, in caso di più violazioni commesse dallo stesso veicolo nell’arco di 60 minuti, venga applicata un’unica sanzione, calcolata sulla base della multa più grave tra quelle accertate, aumentata di un terzo. Questo approccio mira a evitare duplicazioni di sanzioni e garantire una maggiore proporzionalità nel trattamento delle infrazioni.
Nel complesso, la riforma rende più severo il regime sanzionatorio per le violazioni dei limiti di velocità, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e ridurre la sinistrosità.
CdS, uso di dispositivi elettronici alla guida e sospensione breve della patente
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 173 CdS, rafforzando le misure sanzionatorie per chi utilizza dispositivi elettronici durante la guida in violazione delle regole previste. Sebbene l’articolo 173 già disciplinasse il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici, smartphone, tablet, computer portatili e dispositivi analoghi che comportano anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, la riforma del 2024 ha introdotto specifiche sanzioni amministrative e accessorie di maggiore gravità per contrastare più efficacemente questa condotta.
In base al nuovo comma 3-bis, chiunque violi il divieto di cui al comma 2 è ora soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 e 1.000 euro, nonché alla sospensione della patente per un periodo che varia da quindici giorni a due mesi. Inoltre, in caso di recidiva nell’arco di un biennio, le pene vengono aggravate: la sanzione pecuniaria aumenta, passando da 350 a 1.400 euro, e la sospensione della patente è estesa da uno a tre mesi.
Questa nuova disposizione mira a contrastare la distrazione alla guida, che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, e a incentivare l’uso esclusivo di dispositivi a viva voce o auricolari che non richiedono l’uso delle mani.
Va inoltre ricordato che le violazioni gravi, come l’uso del cellulare alla guida, possono incidere sul punteggio della patente. La sospensione breve, disciplinata dall’articolo 218-ter CdS, può essere applicata in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, prevedendo la sospensione della patente per un periodo che varia in base al punteggio residuo del conducente, da sette giorni (se il punteggio è inferiore a 20 ma pari almeno a 10) fino a quindici giorni (se il punteggio è inferiore a 10).
CdS e sospensione breve della patente: durata e applicazione
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 riguarda l’introduzione dell’articolo 218-ter CdS che disciplina la sospensione breve della patente in relazione al punteggio residuo del conducente. Questa misura mira a colpire con tempestività e proporzionalità alcune violazioni specifiche, rafforzando il sistema sanzionatorio e incentivando comportamenti più responsabili alla guida.
L’articolo 218-ter prevede che, in caso di violazioni gravi, la patente possa essere sospesa per un breve periodo direttamente dall’organo accertatore, senza necessità di un provvedimento del Prefetto. La durata della sospensione varia in base al punteggio residuo del conducente al momento dell’accertamento. Nei casi in cui il punteggio sia inferiore a venti ma pari almeno a dieci, la sospensione avrà una durata di sette giorni.
Se il punteggio residuo è inferiore a dieci, la sospensione si estende a quindici giorni. In presenza di un incidente stradale causato dal conducente, anche senza coinvolgimento di terzi, la durata della sospensione è raddoppiata, segnalando l’intento del legislatore di trattare con maggiore severità i comportamenti che comportano un rischio concreto per la sicurezza stradale.
Tra le violazioni che possono comportare l’applicazione della sospensione breve rientrano il mancato rispetto di segnali di senso vietato e divieto di sorpasso, il superamento dei limiti di velocità, l’uso improprio del cellulare alla guida, la guida sotto l’effetto di alcol o droghe, e la mancata osservanza della distanza di sicurezza. L’elenco di tali infrazioni riflette un approccio mirato, volto a intervenire su comportamenti particolarmente pericolosi e spesso causa di incidenti gravi.
La sospensione breve decorre immediatamente dal momento del ritiro della patente da parte dell’agente accertatore e può essere applicata contestualmente alla contestazione della violazione. Se, per qualsiasi motivo, il ritiro non può avvenire contestualmente, la sospensione decorre dalla data di notificazione del verbale. La patente ritirata viene conservata presso l’ufficio dell’organo accertatore fino al termine del periodo di sospensione, dopo il quale sarà restituita al conducente o a un suo delegato. Questa procedura semplificata riduce i tempi amministrativi e garantisce l’efficacia immediata della misura.
Chiunque venga sorpreso a circolare durante il periodo di sospensione incorre in sanzioni severe, che includono una multa amministrativa compresa tra 2.046 e 8.186 euro, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Tali misure accessorie previste dal CdS dimostrano la volontà del legislatore di dissuadere in modo deciso i conducenti dal violare il divieto di guida durante il periodo di sospensione.
Sebbene queste disposizioni siano state accolte positivamente per la loro capacità di garantire una risposta immediata a comportamenti pericolosi, non mancano osservazioni critiche. Alcuni esperti evidenziano che la correlazione tra il punteggio residuo e la durata della sospensione potrebbe non sempre riflettere adeguatamente la gravità dell’infrazione, generando potenziali squilibri. Inoltre, l’efficacia della misura dipenderà dalla capacità degli organi accertatori di applicarla con uniformità e rigore.
Violazioni ripetute nel Codice della Strada (CdS): disciplina delle infrazioni multiple
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 introduce un’importante innovazione nel CdS attraverso la disciplina delle violazioni ripetute, con l’obiettivo di rendere il sistema sanzionatorio più proporzionato e coerente. In particolare, la riforma interviene sull’articolo 142, inserendo il nuovo comma 6-ter, che regola le conseguenze di più infrazioni per il superamento dei limiti di velocità commesse dallo stesso veicolo nell’arco di un’ora. Questa modifica mira a evitare duplicazioni di sanzioni per condotte che, pur reiterate in un breve lasso di tempo, derivano dalla medesima situazione di violazione.
La nuova disciplina prevede che, qualora un veicolo commetta più infrazioni ai limiti di velocità nell’arco di sessanta minuti e all’interno della giurisdizione dello stesso ente, venga applicata un’unica sanzione. In tali casi, sarà calcolata la multa più grave tra quelle rilevate, aumentata di un terzo. Questo approccio consente di punire in maniera proporzionata il comportamento complessivo del conducente, evitando di infliggere pene cumulative che potrebbero risultare eccessivamente gravose. La decorrenza del periodo considerato inizia dalla prima infrazione accertata e si applicano le disposizioni dell’articolo 198-bis del Codice della Strada (CdS), che regolano la continuità delle infrazioni.
La ratio di queste disposizioni risiede nella volontà di garantire un’applicazione più equa e razionale delle sanzioni, riducendo al contempo i rischi di contenzioso. Tuttavia, la loro introduzione non è stata priva di critiche. Alcuni esperti hanno evidenziato che questa semplificazione potrebbe ridurre l’effetto deterrente delle sanzioni, incoraggiando comportamenti meno responsabili da parte di alcuni conducenti. Altri, invece, sottolineano che il calcolo di una sola sanzione potrebbe non riflettere adeguatamente la gravità complessiva delle violazioni commesse in un breve periodo.
ZTL, aree pedonali e il Codice della Strada (CdS): regole per le violazioni multiple
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 introduce significative novità nel Codice della Strada (CdS), disciplinando in modo più razionale e proporzionato le violazioni commesse in Zone a Traffico Limitato (ZTL), aree pedonali urbane e altre zone soggette a limitazioni o divieti di accesso. Le modifiche, in particolare quelle apportate all’articolo 198 tramite l’inserimento del comma 2-bis, mirano a tutelare gli utenti della strada da una moltiplicazione delle sanzioni per infrazioni che, pur ripetute, possono essere considerate come un’unica condotta continuativa.
La nuova disciplina stabilisce che, in caso di più violazioni dello stesso tipo rilevate senza contestazione immediata tramite dispositivi di controllo remoto, venga applicata una sola sanzione per ciascun giorno di calendario. Questo principio si applica anche quando le infrazioni si verificano in fasce orarie diverse o in condizioni in cui le limitazioni si estendono a cavallo di due giorni consecutivi. Ad esempio, se un veicolo accede a una ZTL senza autorizzazione più volte nella stessa giornata, il conducente sarà sanzionato una sola volta per quella specifica giornata.
Questa innovazione normativa è stata concepita per garantire maggiore proporzionalità nel sistema sanzionatorio, evitando situazioni in cui una serie di violazioni possa portare a sanzioni cumulative particolarmente onerose per il conducente. Le sanzioni applicabili restano comunque significative e sono calcolate sulla base delle disposizioni vigenti per ciascun tipo di infrazione. Inoltre, nel caso di violazioni commesse su più giorni distinti, il principio dell’unica sanzione giornaliera non si applica, e ogni infrazione sarà sanzionata separatamente.
L’obiettivo di questa disposizione è duplice: da un lato, promuovere una maggiore equità nel trattamento delle violazioni, dall’altro, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di contenziosi. La riforma al CdS consente agli utenti di comprendere meglio l’entità delle sanzioni e di evitare contestazioni legate alla sovrapposizione di multe per condotte assimilabili.
CdS e obblighi assicurativi: responsabilità del proprietario del veicolo
Tra le novità introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177, una particolare attenzione è rivolta alla responsabilità del proprietario del veicolo per quanto concerne la copertura assicurativa. La modifica all’articolo 193 CdS rafforza gli obblighi in capo al proprietario, ampliando la portata delle responsabilità per prevenire la circolazione di veicoli privi di regolare polizza assicurativa.
Il nuovo testo normativo stabilisce che il proprietario di un veicolo, indipendentemente dall’eventuale cessione del mezzo a terzi, deve vigilare affinché il veicolo sia coperto da un’assicurazione valida. Questo obbligo si applica anche qualora il veicolo venga ceduto a titolo di comodato, locazione o altra forma di disponibilità temporanea. La ratio della norma è evidente: evitare che veicoli non assicurati possano circolare, esponendo gli utenti della strada e i pedoni a rischi economici e legali in caso di incidenti. La modifica rafforza così la tutela collettiva, mirando a ridurre il fenomeno dell’elusione dell’obbligo assicurativo.
L’articolo 193 CdS prevede sanzioni severe per i proprietari inadempienti. Chiunque consenta la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria significativa, oltre al fermo amministrativo del mezzo. Inoltre, la normativa consente alle autorità competenti di procedere al sequestro del veicolo fino alla regolarizzazione della posizione assicurativa. Il proprietario è altresì tenuto a coprire i costi derivanti dalla custodia del mezzo durante il periodo di fermo, aggiungendo un ulteriore aggravio economico per i trasgressori.
Questa innovazione normativa, pur rispondendo a un’esigenza di maggiore controllo e sicurezza, non è esente da critiche. Alcuni esperti hanno sottolineato che l’obbligo di vigilanza potrebbe risultare eccessivamente gravoso per i proprietari che concedono l’uso del veicolo a terzi in buona fede. In particolare, la responsabilità diretta del proprietario rischia di penalizzare chi non ha strumenti concreti per verificare costantemente la validità della polizza assicurativa, soprattutto in caso di utilizzi sporadici o temporanei del mezzo.
Nonostante queste perplessità, la riforma appare coerente con l’intento del legislatore di contrastare il fenomeno della circolazione senza copertura assicurativa, che rappresenta una delle principali cause di incertezza nella gestione degli incidenti stradali. La maggiore responsabilizzazione del proprietario si affianca a strumenti tecnologici sempre più avanzati, come i sistemi di rilevazione automatica, che consentono di individuare rapidamente i veicoli non assicurati.
Micromobilità e il Codice della Strada (CdS): nuove regole per monopattini e dispositivi elettrici
La Legge 25 novembre 2024 n. 177 introduce nel Codice della Strada (CdS) un quadro normativo più stringente per regolamentare l’uso dei dispositivi di micromobilità, con particolare attenzione ai monopattini elettrici. Questi mezzi, sempre più diffusi nelle aree urbane, sono stati al centro di un acceso dibattito per i rischi connessi alla loro circolazione e per l’assenza, fino a oggi, di regole uniformi. La riforma mira a garantire maggiore sicurezza per gli utenti e per i pedoni, attraverso una serie di disposizioni che disciplinano non solo l’uso dei monopattini, ma anche le modalità di parcheggio e i requisiti tecnici.
Tra le novità principali (apportate modificando la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e non direttamente il CdS), vi è l’introduzione dell’obbligo di assicurazione RC, una misura che pone i monopattini sullo stesso piano degli altri veicoli a motore in termini di responsabilità civile. L’obiettivo è quello di tutelare tutte le parti coinvolte in caso di incidenti, garantendo un adeguato risarcimento per eventuali danni causati da questi dispositivi. A ciò si aggiunge l’obbligo del casco per tutti i conducenti, senza distinzione di età, con una chiara volontà di ridurre il numero di incidenti gravi e lesioni legate alla scarsa protezione individuale.
Per quanto riguarda il parcheggio, la riforma stabilisce il divieto di sosta sui marciapiedi, salvo specifiche deroghe comunali. Questa misura risponde all’esigenza di evitare che i monopattini parcheggiati in modo disordinato costituiscano un ostacolo per i pedoni, in particolare per le persone con disabilità, e che compromettano il decoro urbano. Le amministrazioni locali saranno chiamate a regolamentare le modalità di sosta, prevedendo spazi dedicati per questi dispositivi, al fine di favorire un utilizzo più responsabile.
Le sanzioni per chi non rispetta le nuove disposizioni sono particolarmente incisive, con multe da 200 a 800 euro, a seconda della gravità della violazione. L’introduzione di tali sanzioni dimostra la volontà del legislatore di adottare un approccio più rigido nei confronti degli utenti di monopattini elettrici, spesso accusati di comportamenti imprudenti o pericolosi.
Nonostante le critiche, la riforma si configura come un tentativo di bilanciare l’innovazione con la sicurezza, rispondendo a un’esigenza reale di regolamentare la micromobilità in modo più efficace. Le nuove regole riflettono l’intento del legislatore di promuovere un uso responsabile dei monopattini elettrici, incentivando al contempo le amministrazioni locali a predisporre le infrastrutture necessarie per integrare questi mezzi nel sistema di mobilità urbana.
Resta ora da verificare se l’effetto deterrente delle sanzioni e l’applicazione uniforme delle regole saranno in grado di migliorare la sicurezza e l’ordine nelle città italiane, senza penalizzare eccessivamente gli utenti della micromobilità.
Sorpasso e velocipedi nel Codice della Strada (CdS): distanza di sicurezza obbligatoria
Una delle modifiche più significative introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177 al Codice della Strada (CdS) riguarda il sorpasso dei velocipedi, con particolare attenzione alla sicurezza di questa categoria di utenti vulnerabili della strada. La nuova disciplina, che interviene sull’articolo 148 CdS, stabilisce l’obbligo per i veicoli a motore di mantenere una distanza laterale minima di 1,5 metri durante il sorpasso di biciclette, introducendo così una regola chiara e uniforme per ridurre i rischi di incidenti.
La norma impone al conducente che intenda sorpassare un velocipede di verificare preventivamente che la strada sia libera, che la manovra possa essere effettuata senza pericolo e che le condizioni di visibilità e spazio siano adeguate. La distanza di sicurezza laterale deve essere calcolata tenendo conto della velocità relativa dei mezzi e dell’ingombro del veicolo a motore, in modo da garantire la stabilità del velocipede e prevenire situazioni di pericolo per il ciclista. L’obiettivo di questa disposizione è quello di ridurre le situazioni di rischio derivanti da sorpassi troppo ravvicinati, che possono facilmente portare a cadute o a incidenti gravi.
Le sanzioni per la violazione di questa regola sono significative: il conducente che non rispetta la distanza di sicurezza è soggetto a una multa compresa tra 167 e 665 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi, secondo le disposizioni del Codice della Strada (CdS). Nei casi in cui il trasgressore sia un neopatentato, ossia in possesso della patente da meno di tre anni, la durata della sospensione è aumentata a un periodo compreso tra tre e sei mesi, a conferma della maggiore severità applicata ai conducenti meno esperti.
Questa modifica al CdS riflette la crescente attenzione del legislatore verso la protezione degli utenti più vulnerabili, in linea con gli obiettivi di sicurezza stradale promossi a livello europeo. La distanza minima di 1,5 metri, già adottata in altri Paesi dell’Unione Europea, rappresenta uno standard importante per garantire un livello di protezione adeguato ai ciclisti e per promuovere una cultura della condivisione responsabile della strada.
Tuttavia, l’introduzione di questa norma non è stata priva di critiche. Alcuni osservatori hanno evidenziato difficoltà pratiche nell’applicazione della regola in contesti urbani caratterizzati da strade strette o traffico intenso, dove il mantenimento della distanza laterale potrebbe non essere sempre possibile senza compromettere la fluidità della circolazione. Altri hanno sottolineato la necessità di accompagnare questa misura con una maggiore educazione stradale, rivolta sia ai conducenti di veicoli a motore sia ai ciclisti, per favorire un rispetto reciproco delle regole.
Motocicli 125 cc e il Codice della Strada (CdS): condizioni di circolazione su autostrade
Tra le novità introdotte dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177, una delle più attese riguarda la possibilità, regolata dall’articolo 175 del Codice della Strada (CdS), di consentire ai motocicli di cilindrata 125 cc di circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, purché vengano rispettate specifiche condizioni. Questa modifica, introdotta con il nuovo comma 2-bis, rappresenta una significativa apertura per i conducenti di veicoli di piccola cilindrata, offrendo loro una maggiore libertà di movimento, ma subordinata a rigidi requisiti di sicurezza.
La normativa di riforma al CdS prevede che i motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc se a motore termico, o di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico, possano circolare su queste strade, ma esclusivamente se condotti da persone maggiorenni. La restrizione mira a garantire che tali veicoli siano utilizzati da conducenti con una maggiore esperienza e maturità, riducendo il rischio di incidenti in contesti di traffico veloce e complesso, come quelli autostradali.
Questa deroga ai divieti tradizionalmente imposti dall’articolo 175 del Codice della Strada (CdS) risponde alla necessità di allinearsi alle tendenze europee in materia di mobilità leggera, consentendo un utilizzo più versatile dei motocicli di piccola cilindrata. Tuttavia, restano in vigore i divieti per veicoli con cilindrata inferiore a 120 cc o con potenza inferiore a 6 kW, nonché per i motocicli condotti da conducenti minorenni, confermando l’approccio prudenziale adottato dal legislatore.
Nonostante le opportunità offerte da questa modifica, la misura non è stata accolta unanimemente. Alcuni esperti hanno espresso preoccupazioni riguardo ai rischi potenziali per i conducenti di motocicli 125 cc, soprattutto in situazioni di traffico intenso o in presenza di veicoli pesanti. In particolare, l’assenza di adeguate barriere protettive o di corsie di emergenza sufficientemente ampie potrebbe rappresentare un pericolo significativo per questi utenti della strada.
Conclusioni: un Codice della Strada (CdS) più severo e moderno, ma con margini di criticità
La Legge 177/2024 ha introdotto un significativo aggiornamento del Codice della Strada (CdS), con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e adeguare la normativa alle nuove esigenze di tutela degli utenti della strada.
Tra le principali novità si segnalano le restrizioni imposte ai neopatentati, con limiti di potenza dei veicoli e obblighi formativi aggiuntivi; la disciplina della sospensione breve della patente, applicabile in base al punteggio residuo e pensata per sanzionare condotte specifiche, come l’eccesso di velocità o il mancato rispetto della distanza di sicurezza; e le nuove regole per la micromobilità elettrica, che introducono l’obbligo di casco e polizza assicurativa per i monopattini. Di altre novità, riguardanti la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, abbiamo trattato in un precedente articolo.
Sono stati inoltre introdotti il regime di accorpamento delle sanzioni per violazioni multiple ai limiti di velocità commesse in breve tempo e le modifiche all’articolo 173, con sanzioni più severe per l’uso improprio di dispositivi elettronici alla guida. Ulteriori innovazioni riguardano la sicurezza dei veicoli, con l’obbligo per i costruttori di avviare campagne di richiamo per correggere difetti che potrebbero compromettere la sicurezza, e la regolamentazione del sorpasso dei velocipedi, che impone una distanza minima laterale di 1,5 metri.
Da ultimo, il nuovo CdS prevede la possibilità per i motocicli 125 cc di circolare su autostrade, purché condotti da soggetti maggiorenni, e l’impiego delle auto di sicurezza per la regolazione del traffico in situazioni di emergenza.
Queste modifiche rappresentano un passaggio importante verso una mobilità più sicura e sostenibile, ma pongono anche sfide interpretative e applicative che richiederanno un costante monitoraggio.
Lo Studio Legale D’Agostino, forte di una consolidata esperienza in materia di infortunistica stradale e nel settore del Codice della Strada (CdS), è a disposizione per fornire consulenza e assistenza legale. Siamo pronti a supportare privati e aziende nella gestione di contenziosi e nella tutela dei diritti.
Contattaci qui

Codice della Strada (CdS): assistenza legale con lo Studio Legale D’Agostino a Roma per sanzioni e ricorsi in materia di circolazione stradale.